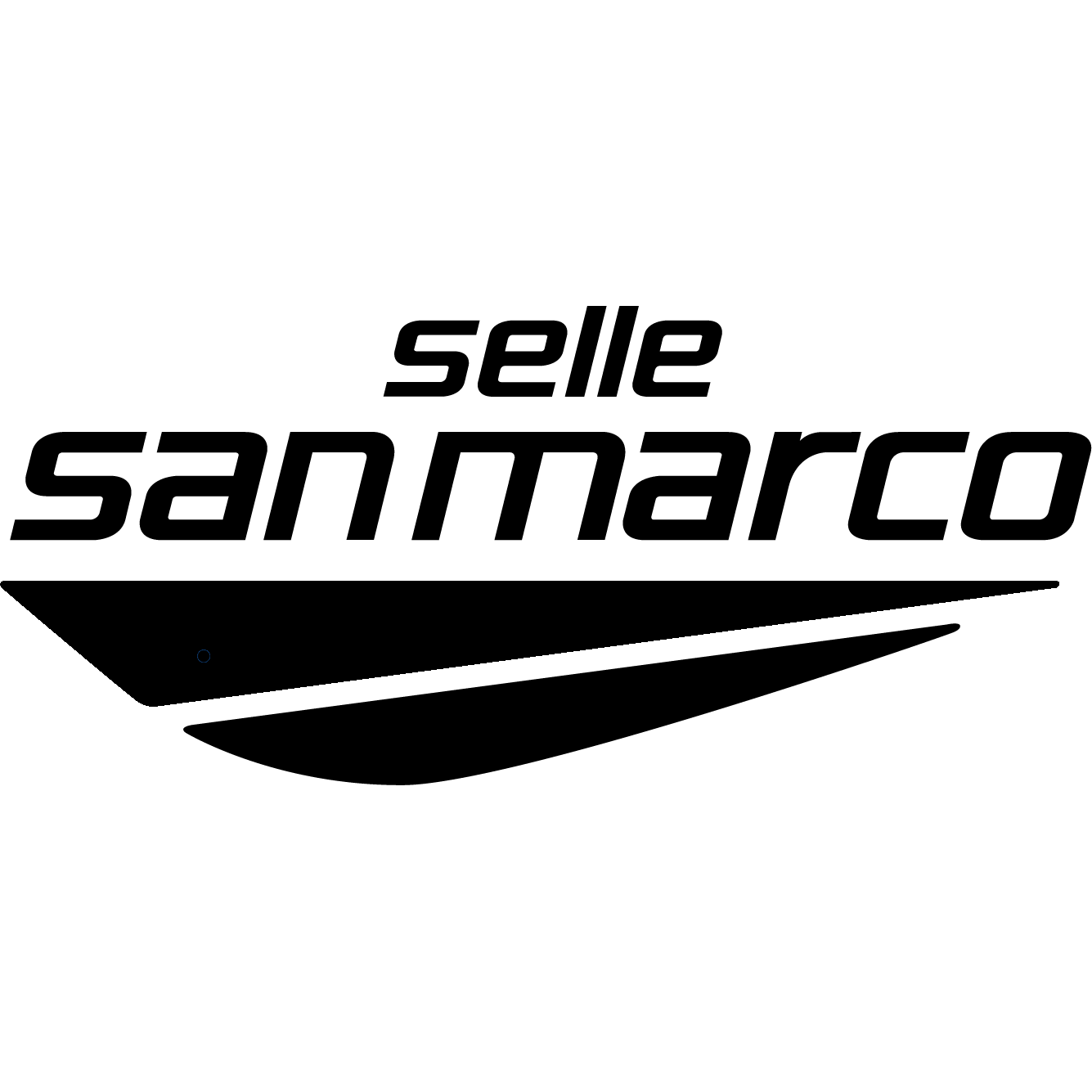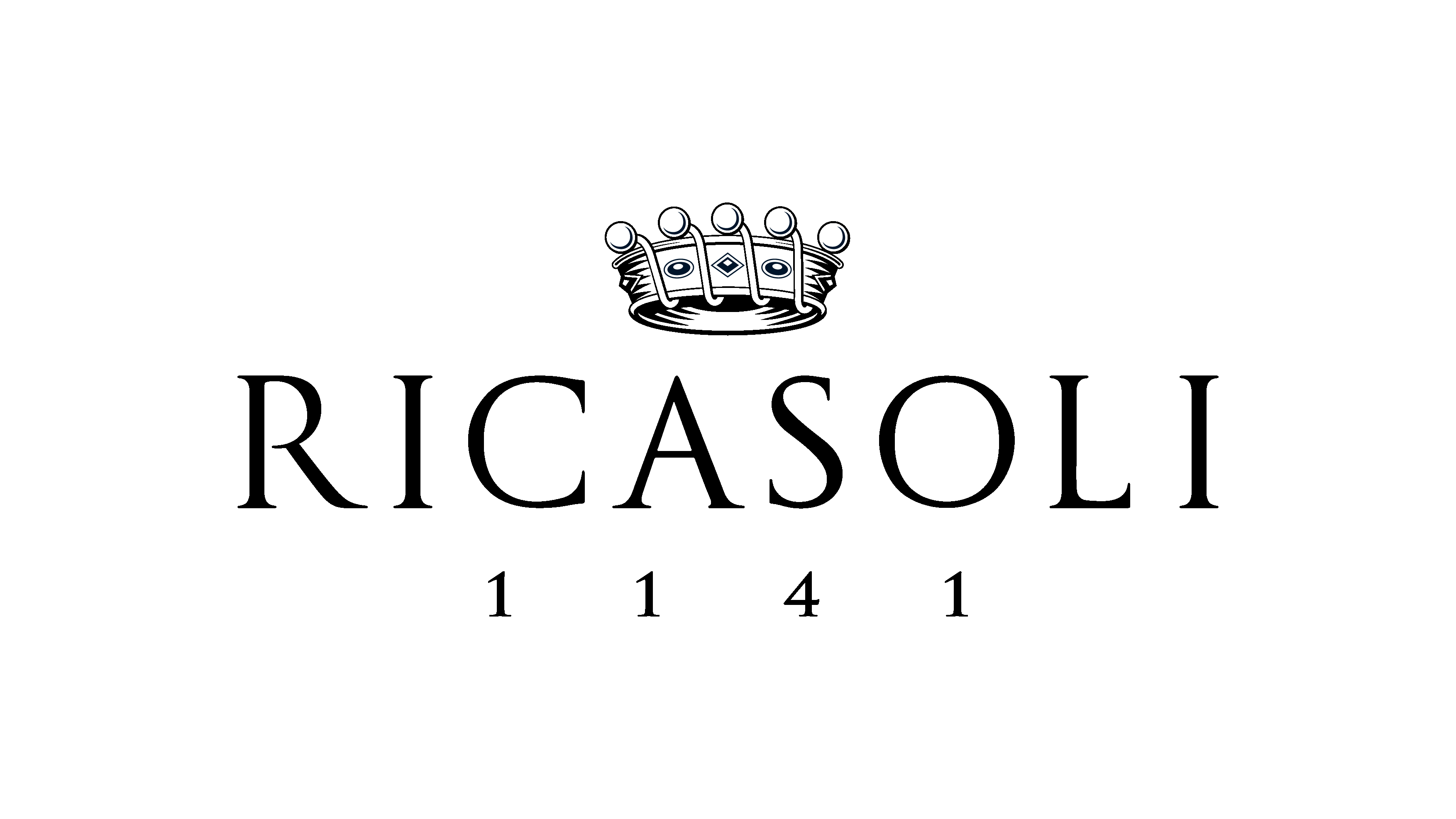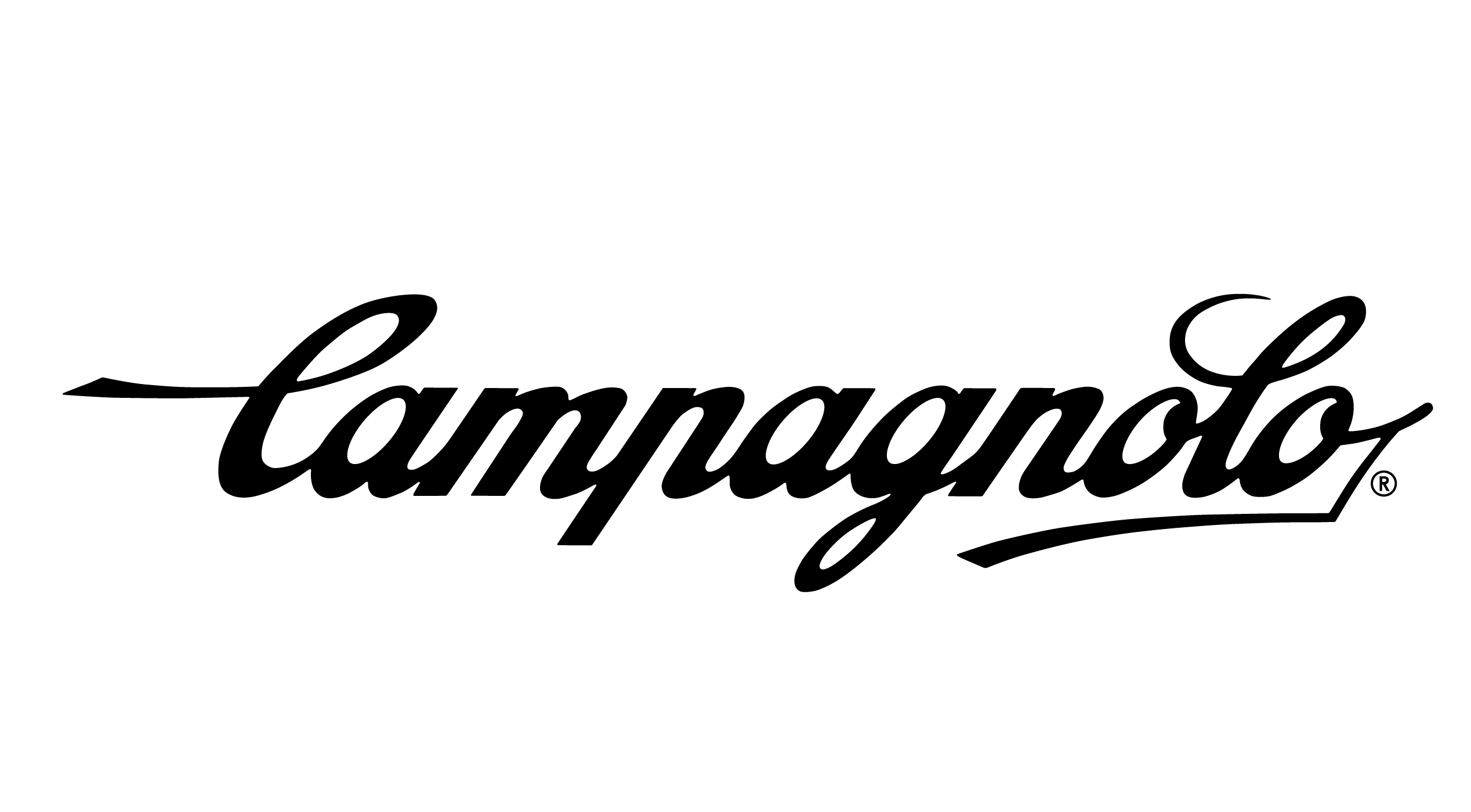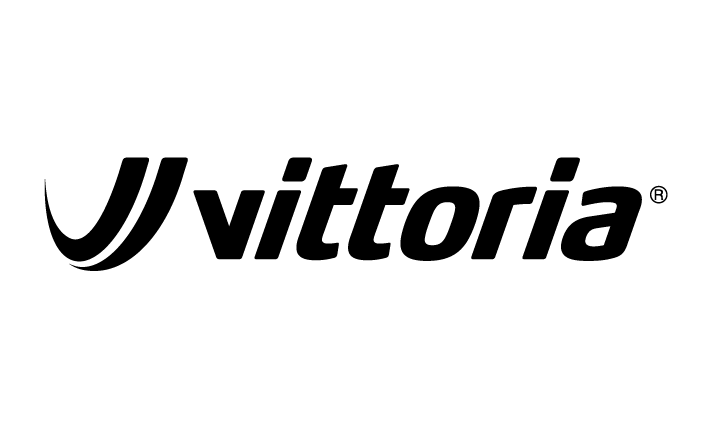Quando le ruote dei corridori incontrano le pietre di Francia si entra in un altrove ciclistico.
Quando le ruote dei corridori incontrano le pietre di Francia si entra in un altrove ciclistico. Nulla di ciò che si prova in quel fazzoletto di terra al confine con le Fiandre può essere replicato in un altro luogo. Lassù al nord tutto è sospeso in una dimensione temporale a sé, cristallizzata nel tempo, che ha scelto di non mutare. È corsa che vaga per campagne da sempre, che da sempre supera strade di pietra antiche ben più del ciclismo, che per genesi piomba in un velodromo per decretare vincitore e vinti. Ancor oggi che gli anelli di pista questo sport se li è dimenticati. Quello di Roubaix è rimasto intatto, con le sue mini paraboliche e le sue docce dell’anteguerra, scrigno per un gioiello da preservare: la Parigi-Roubaix.
Perché la Roubaix è una bestia rara. Era in via d’estinzione ancor prima che partisse la prima edizione. Fosse stato per Victor Breyer non si sarebbe mai corsa. Fu lui a essere inviato dal quotidiano Le Vélo per verificare la fattibilità di una corsa che unisse la capitale al nuovo velodromo costruito lassù. Era il 1896, di febbraio, quando su una bicicletta di quasi venti chili pedalò in una tormenta di pioggia e vento, su “strade che sarebbero da vietare”, per poi arrivare in “modestissimo velodromo scoperto”. Scrisse che era “da evitare come la peste” l’idea di fare una corsa del genere. Scrisse che era “pericoloso e soprattutto incosciente far correre i corridori su queste strade”. Scrisse tante altre cose. Ma non inviò mai questo telegramma. Preferì un molto più semplice “per me va bene”, in pratica un visto, si corra.
Era in via d’estinzione già alla prima edizione. Era il 1896, il 19 aprile. L’arcivescovo di Parigi e quello di Lilla si adirarono contro la decisione di correre il giorno di Pasqua. Gli organizzatori si industriarono per celebrare una messa alla partenza e una all’arrivo. Partirono in 52 dalla capitale francese. Arrivarono in 28 (o forse in 32) al confine con le Fiandre. Josef Fischer prima di tutti gli altri, ma messo come tutti gli altri, cioè male. Il lussemburghese era finito a terra una volta da solo, una volta a causa di un cavallo che l’aveva speronato e una volta a causa di una mandria di mucche che aveva attraversato la strada. Andò peggio al gallese Arthur Linton che ci finì sei volte steso sulle pietre e arrivò al traguardo in stato di semi incoscienza. Andò ancora peggio a Albert Dumas, ultimo classificato, a venti ore da Fischer: aveva preso la strada sbagliata, aveva allungato il percorso di oltre cento chilometri, guadando un fiume e scappando da un contadino che lo voleva picconare per essere entrato nella sua proprietà.
Era in via d’estinzione anche alla seconda edizione. Era il 1897, il 18 aprile. E solo trentadue atleti si presentarono al via. Ma quando il valdostano Maurice Garin, che sei anni più tardi vinse il primo Tour de France della storia, passò il traguardo e disse a tutti “questa corsa è una follia, questa corsa è la più bella a cui io ho partecipato”, allora tutti decisero che forse non era poi così male correre lì.
Era in via d’estinzione anche negli anni Settanta. Di strade in pavé ce ne erano sempre meno e quelle che resistevano alla modernità erano messe sempre peggio. Un manipolo di uomini di buona volontà decisero che la Roubaix non poteva sparire e si misero a sistemare i settori come atto d’amore a quella corsa e al ciclismo in generale. Ancora oggi Les Amis de Paris-Roubaix curano le pietre, danno la possibilità ai corridori di attraversare l’Inferno del Nord. Lo chiamano così, perché correre quassù è una faticaccia bestiale, infernale. Ma è l’inferno migliore che si possa immaginare: un Paradiso di passione e biciclette.
Giovanni Battistuzzi